|
Giorgione a Montagnana (parte quinta)
di Enrico Maria Dal Pozzolo
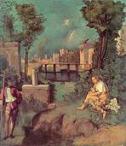 La centralità delle figure di David e Giuditta nell'una e nell'altra storia - ebraica e cristiana -
rappresenta davvero l'ideale punto di giuntura, il ramo d'ulivo di fronte alle mille controversie che
laceravano un tessuto religioso originariamente omogeneo. Essi, grazie alla loro vittoria sul male,
preludono in ogni luce alla salvezza, al riscatto dalla colpa di Adamo ed Eva; cosicché la relazione
coi progenitori è altrettanto sentita di quella con Gesù e Maria, e in una prospettiva giorgionesca
ciò induce a riflettere dopo l'interpretazione avanzata da Salvatore Settis per la Tempesta.
La centralità delle figure di David e Giuditta nell'una e nell'altra storia - ebraica e cristiana -
rappresenta davvero l'ideale punto di giuntura, il ramo d'ulivo di fronte alle mille controversie che
laceravano un tessuto religioso originariamente omogeneo. Essi, grazie alla loro vittoria sul male,
preludono in ogni luce alla salvezza, al riscatto dalla colpa di Adamo ed Eva; cosicché la relazione
coi progenitori è altrettanto sentita di quella con Gesù e Maria, e in una prospettiva giorgionesca
ciò induce a riflettere dopo l'interpretazione avanzata da Salvatore Settis per la Tempesta.
Un indizio prezioso nella possibilità che questa Giuditta, oltre che Maria, adombri anche la figura
di Eva è dato dal fatto che, se ben si osserva, il suo atteggiamento dipende dal tipo della cosiddetta
Venere pudica classica: con le mani a coprirsi il petto e, reggendo la spada, alla parte bassa del bacino.
In ciò, se da un lato si coglie una connotazione puramente elogiativa della bellezza di lei -
di "incomparabile splendore", come specifica il testo sacro (Giuditta, 8, 7; 10, 4) - dall'altro si
sottolinea l'appartenenza ad un preciso filone iconografico che utilizzava tale archetipo per
rappresentare Eva resa conscia delle proprie nudità: un filone assai colto che, nel Veneto del
Quattrocento, annovera i nomi di Gentile da Fabriano, Pisanello e Jacopo Bellini. Si noti come
il pittore ponga la spada entro tale schema, quasi a voler sottolineare la virtuosa difesa dell'integrità,
fisica e morale, dell'eroina.
A livello figurativo una giustapposizione di tali personaggi (Eva-Giuditta-Maria e Adamo-David-Gesù)
è espressa da Pellegrino da San Daniele nelle ante d'organo dipinte per il Duomo di Udine
(ora nel Museo Civico della stessa città) e poi, basandosi sui medesimi cartoni, negli affreschi della
chiesa di Sant'Antonio Abate a San Daniele del Friuli. Il caso ci pare segnalabile per due motivi.
Il primo è che il pittore friulano conobbe bene senza dubbio , se non Giorgione, quanto meno la sua
opera, dal momento che proprio negli affreschi di San Daniele cita letteralmente il San Nicasio della
Pala di Castelfranco, in una i quelle rare desunzioni della cui rilevanza abbiamo fatto un accenno
in precedenza. Il secondo è che viene appunto a produrre la doppia, coerentissima, catena a cui
accennavamo.
Ma mentre egli la specifica, per così dire, a livello di glossa e la utilizza in funzione
divisoria dei riquadri principali (le figure di Adamo, Eva, David e Giuditta appaiono come sculture
esterne alla sequenza delle due Adorazioni - dei Pastori e dei Magi - e sotto l'Annunciazione),
al contrario l'autore degli affreschi di Montagnana presuppone tali relazioni senza chiarirle,
lasciando quindi il messaggio avvolto sotto gli spessi panni di una pura figurazione allegorica.
Ciò prende uno spicco eccezionale se si considera come egli viene ad inserire i dipinti nella
retrofacciata della chiesa. David e Giuditta sono infatti posti rispettivamente a sinistra e a
destra del portale maggiore, in uno sviluppo narrativo che prevede ampie cadenze e gioca su di
un dilatato dialogo fra pieni e vuoti. Purtroppo l'originaria partizione degli spazi è stata
compromessa dall'apertura delle nicchie e dall'allargamento del portale.
 Tuttavia non è difficile intendere ancor oggi il tentativo del pittore di costruire una sequenza fluida
che fosse nel contempo prospetticamente accentrata. Infatti le due figure, dai moti rispondenti nella
lieve convergenza ogivale, sono concepite come "monito" ed "annuncio" per coloro che, uscendo dalla chiesa,
alzano gli occhi:
Giuditta si rivolgeva alle donne, che tradizionalmente durante le funzioni religiose occupavano la
parte sinistra della navata, David agli uomini, che stavano invece a destra. Grazie ai due enormi
finestroni da cui esse s'affacciano, il muro era quindi squarciato e s'apriva un paesaggio di rara
bellezza, con un cielo dilagante, che bagnava d'azzurro le colline sfumanti, basse, all'orizzonte.
Tuttavia non è difficile intendere ancor oggi il tentativo del pittore di costruire una sequenza fluida
che fosse nel contempo prospetticamente accentrata. Infatti le due figure, dai moti rispondenti nella
lieve convergenza ogivale, sono concepite come "monito" ed "annuncio" per coloro che, uscendo dalla chiesa,
alzano gli occhi:
Giuditta si rivolgeva alle donne, che tradizionalmente durante le funzioni religiose occupavano la
parte sinistra della navata, David agli uomini, che stavano invece a destra. Grazie ai due enormi
finestroni da cui esse s'affacciano, il muro era quindi squarciato e s'apriva un paesaggio di rara
bellezza, con un cielo dilagante, che bagnava d'azzurro le colline sfumanti, basse, all'orizzonte.
Oltre che ad una funzione formale, le due aperture assolvono però anche ad un compito di natura
iconografica, concorrendo alla specificazione del valore prefigurativo che abbiamo appena messo in rilievo.
Infatti conosciamo i casi di alcuni profeti che trovano spazio - entro un polittico ad esempio -
grazie a simile espediente. Fra questi spicca proprio il David il quale, con la sua fuga da Saul
attraverso una finestra (1 Re 19,12), spesso nella tradizione patristica è stato paragonato al Cristo
risorto e disceso al limbo.
E nel solco della tradizione ebraico-cristiana un commentatore antico
(Ippolito di Roma, autore di una storia di David e Golia in cui si cimenta a svelare ogni corrispondenza
col Messia) così esclama: "Veni, consiste, propheta, testificare et dic : Fenestrae apertae sunt in
caelis". In tale luce ci sembra che vadano guardati i due eroi di Montagnana, tenendo ben presente,
peraltro - ed il ponte si rafforza ulteriormente - che in questi anni la finestra è usata simbolicamente
per lo più come attributo di Cristo e Maria (Fenestra incarnationis e Fenestrae coeli). In tal senso
si spiega l'analogia dell'impostazione qui adottata con quella di taluni dipinti del secondo Quattrocento
in cui la Vergine e il figlio si rivolgono allo spettatore proprio da finestre marmoree.
Prendendo spunto da un bel paesaggio di Bialostocki, si potrebbe metaforizzare affermando che, come
in certe pupille disegnate dal Dùrer, nell'occhio di chi fissa con adeguata consapevolezza teologica
i due precursori così "incorniciati" si riflettono finestre a forma di croce.
Considerando allora simile densità di valenze significanti, stupisce di trovare David e Giuditta in
una chiesa di provincia, così provocatoriamente sbandierati al popolo. Essi non potevano che risultare
sintesi in interpretabili, emblemi muti.
Tutto ciò va poi innestato all'interno di un contesto sociale
in cui sembra difficile riconoscere, di questi tempi, un personaggio tale da suggerirne la commissione:
si pensi solo che in Duomo non c'era neppure l'arciprete, ma un vicario. Verrebbe da credere -
ma nulla lo può provare - che sia stato il pittore stesso a suggerire tali soggetti; o comunque chi ne
conosceva la predisposizione. E, sia detto per inciso (ma è dato di non poco peso), del Marescalco non
ci è giunto alcun dipinto trattante simili tematiche.
|

